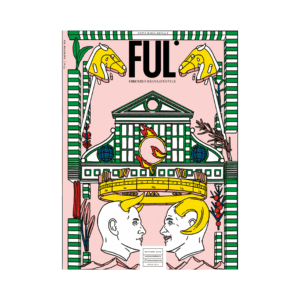Il Festival dei popoli si è concluso ormai da più di dieci giorni, ma gli interventi che ne hanno caratterizzato questa edizione meritano una lunga riflessione che la nostra Barbara Palla vuole proporvi nell’osservare il mondo con la prospettiva del migrante.
Quel momento in cui si cerca di attraversare il confine e si viene fermati dalla polizia per la maggior parte delle persone è solo l’inizio di un incubo, per altri è la quotidianità. Così come cercare posti di fortuna per dormire o rimanere confinati in una struttura senza luce naturale e senza finestre. Tutte prospettive alle quali vanno incontro coloro che scappano dalla guerra, dalla repressione politica, dalla fame e povertà. Ma sono anche le prospettive che i registi de Festival dei Popoli hanno provato a rappresentare per far vivere allo spettatore quella stessa esperienza.

Il Festival internazionale del Film Documentario, svoltosi a Firenze tra il 27 novembre e il 2 dicembre, ha presentato i documentari che hanno riscosso maggiore successo nei principali eventi cinematografici internazionali. È stata così l’occasione per vedere da prospettive nuove il mondo che cambia e poterne discutere da una posizione privilegiata.
La sezione Looking For Neverland, quest’anno si è soffermata sulle tematiche legate al viaggio, all’abbandono, oltre alle contorte problematiche dell’essere un richiedente asilo. Lo ha però proposto in modo diverso, attraverso le immagini in prima persona. I grandi media internazionali hanno saturato lo spazio dell’informazione con le immagini delle grandi masse incolonnate lungo la rotta balcanica, raggruppate al confine come a Idomeni, stipate sulle barche alla deriva a largo delle coste turche, greche, libiche e italiane. Il Festival propone invece di entrare nel particolare, abbandonare il generale in favore del dettaglio, dell’esperienza singola, di quello che si vive sulla pelle. I migranti, o transitanti che dir si voglia, diventano i protagonisti, raccontano e vivono insieme allo spettatore la paura, il compromesso, la precarietà e la solitudine.
La tecnica documentaristica si rinnova per per dare spazio all’interpretazione personale, alla condivisione. Il migrante diventa anche regista aggiunto, come nel caso di Bunkers di Anne-Claire Adet (giovane regista autodidatta che si cimenta per la prima volta in un cortometraggio, dopo aver realizzato dei filmati per le principali NGO). La storia è quella dei richiedenti asilo in Svizzera costretti a vivere all’interno dei rifugi anti-atomici costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale; una storia raccontata da Mohammed, uno degli abitanti del Bunker, al quale la regista ha dato un cellulare per mostrarne l’interno. Attraverso le immagini strette e verticali, tipiche della telecamera del telefono, si scoprono le stanze sempre illuminate, sovraffollate, di un appartamento sotterraneo privo di finestre. Un ambiente angosciante, nel quale l’intimità diventa un lusso, un luogo dal quale non si può scappare.
Una scelta simile è stata effettuata da M. Siedebert, E. Wagner (regista specializzato nel raccontare le tematiche attraverso la lente dei suoi protagonisti) per il loro lungometraggio Les Sauteurs -Those Who Jump. I due registi hanno incontrato in Marocco i numerosi migranti-transitanti che vivono sul Monte Gurugù, proprio di fronte all’enclave spagnola di Melilla. Per comprendere il precario equilibrio della vita in un campo profughi improvvisato, essi hanno affidato a Abou Bakar Sidibé, uno dei migranti, una telecamera e il compito di riprendere e commentare la sua quotidianità. Lo spettatore viene dunque proiettato in medias res finendo per vivere insieme al protagonista, nonché co-regista, l’angoscia della notte nel campo, il timore di rimanere bloccato, il terrore nell’affrontare la polizia di frontiera e infine la paura di aver viaggiato invano. Solo attraverso i discorsi, in qualche modo intimi, dei migranti-transitanti in attesa, si intravedono lineamenti dell’El-Dorado che rappresenta l’Europa ai loro occhi. Solo così, si iniziano a percepire le motivazione e le vere necessità del voler “diventare europei”.
No Borders di Haider Rashid, iracheno di origine ma fiorentino di nascita, tratta lo stesso argomento, ma con un artificio tecnologico molto più interessante. Rashid realizza infatti il primo documentario italiano internamente in realtà virtuale (VR). Le riprese a 360° portano lo spettatore al centro dell’azione. Attraverso il visore di VR, che si monta sul viso come un paio di occhiali, si entra dentro il film. No Borders diventa così un “film da indossare” come dice lo stesso Elio Germano, voce narrante e secondo protagonista, alla presentazione al Teatro la Compagnia, un’esperienza che mette lo spettatore a tu per tu con gli attivisti del Centro Sociale Baobab di Roma e a confronto della polizia di frontiera sugli scogli di Ventimiglia.
Il Festival però non è solo una rassegna cinematografica, è anche l’occasione per incontrarsi e discutere insieme dei problemi che emergono nei documentari in programma. La tavola rotonda, La barca è piena?, offre inaspettatamente la possibilità di un ulteriore mutamento del punto di vista. Anche in questo caso, il racconto di esperienze vissute in presa diretta, scalza la generalizzazione di un racconto della massa in favore della descrizione dell’elemento particolare e delle sue sfaccettature.
Nelle parole di Luca Achilli, antropologo specializzato nello studio del problema dei rifugiati in Medio Oriente, si coglie la difficoltà di definire il ruolo dei passeurs. Spesso identificati come cinici strozzini pronti a fare fortune sulle spalle dei migranti, si scopre come in realtà essi siano degli ex-migranti che hanno deciso di fornire un servizio ai propri connazionali. Sì, connazionali. I passeurs, per esperienza diretta di Achilli che si è recato sulla rotta balcanica per percorrerla, sono loro stessi curdi, siriani, libici, maliani, nigeriani con i quali i migranti-transitanti rimangono spesso anche in buoni rapporti. Il passeur diventa dunque, in alcuni casi, un riferimento al quali affidarsi nel momento in cui si affronta un viaggio pieno di incognite sia dal punto di vista della destinazione che del tempo.
La consapevolezza che il fenomeno della migrazione è destinato a durare ancora per molti anni è un po’ il filo che lega i dibattiti ai film. Per cui l’impegno preso nel raccontare la particolarità di un fenomeno così massiccio diventa fondamentale per afferrare i molteplici aspetti delle storie personali di chi ha deciso di cambiare la propria prospettiva.
Barbara Palla