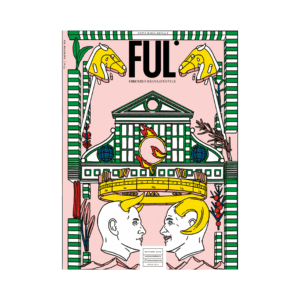La scrittrice e illustratrice Arianna Papini si racconta, e ci racconta come nascono i suoi personaggi immaginifici, perché ha deciso di fare l’arteterapeuta e come essere felici con meno oggetti e più fantasia.
Martedì 14 gennaio l’artista fiorentina sarà ospite di Wunderkit, la rassegna dedicata agli “artigiani creativi” che raccontano le loro storie personali e professionali dai risvolti inaspettati, usando cinque oggetti come innesco di ricordi, storie e ispirazioni (inizio ore 19 – ingresso libero previa registrazione su https://wunderkit_arianna-papini.eventbrite.it).

Senza svelare quali oggetti porterai, ci puoi dare qualche anticipazione sul tema, sul filo rosso che li collega?
Non li ho ancora scelti. Anzi, ne ho scelti solo due, ma con un punto interrogativo. Questa richiesta di scegliere solo cinque oggetti è una scommessa immensa. Credo che la vita di ognuno di noi sia fatta di migliaia di piccoli pezzi, proprio come i mosaici bizantini. Apparentemente hanno tutti poca importanza, ma se ne togliamo uno vediamo subito che lì manca qualcosa, non luccica più, la luce non si appoggia alla superficie, ma la dimentica e diventa ombra, a volte buio.
Direi che il filo rosso è “l’inizio”. Adoro l’inizio di tutte le cose. L’inizio delle persone nell’essere piccolissime, neonate, con quell’aria antica e le rughe arrossate dal pianto. L’inizio delle giornate con le loro albe nebbiose oppure terse, pronte alla mia arte e al mio dire, che è sempre troppo. Il filo rosso è questo: ogni inizio, ogni affettività.
Nel 2018 hai vinto il Premio Andersen come miglior illustratrice, in quella occasione hai sottolineato che vincerlo implica una responsabilità, ce ne parli?
Il nostro è un mestiere strano. Sempre in lotta e in bilico tra il nascondersi nell’intimità del fare arte e il doversi mostrare agli altri. Perché l’arte senza sguardo altrui non esiste, ed è stupefacente quando ti accorgi che gli occhi degli altri approvano ciò che esce da te.
Secondo me non esiste una bravura; esiste un fare piccolo, con le mani, con i colori e gli odori dell’esistenza, esiste la verità e la comunicazione. Nel crescere come artisti e scrittori, che è la stessa cosa, è necessario togliere le parole superflue, gli oggetti inutili, gli elementi decorativi. Restano l’essenza, il messaggio. Quando questa essenza arriva agli altri e una giuria importante decide di premiarti allora hai uno sbandamento; il tuo mestiere diventa pubblico ed è rischioso perché un premio così importante può abbagliarti, distrarti dal tuo fare piccolo e vero. E poi ci sono tutti gli altri, i tuoi compagni di viaggio. Loro non sono stati premiati, ti chiedi perché e ti dispiace. Lì sta la responsabilità. Un premio così non basta vincerlo, devi riuscire a portarlo avanti per dimostrare, prima di tutto a te stesso, di meritarlo veramente.
Come ti sei avvicinata all’arte terapia e come influenza il tuo lavoro di illustratrice?
È stato così strano. Leggevano i miei libri nelle scuole e mi chiamavano per i laboratori. In quelle occasioni creavo luoghi densi di condivisione e i bambini rispondevano donandomi i loro segreti. Ad esempio, una volta una bimba raccontò per la prima volta ai suoi compagni di essere stata adottata; nessuno lo sapeva. Ma è solo quando ho partecipato al convegno “L’arte che cura” che ho riconosciuto ciò che da tanti anni facevo e che fino a quel momento non avevo saputo definire. Così, mi sono iscritta alla bellissima scuola di Bologna, Art Therapy Italiana e ho iniziato a lavorare con gruppi e pazienti.
Ed è grazie a questa formazione che ho avuto la possibilità di ampliare la mia arte. Infatti, nell’arteterapia non conta l’estetica, l’oggetto finale, ma è importante l’osservazione e la condivisione del processo creativo. Ho cominciato a perdere di vista l’intento estetico e lì la mia arte ha avuto un’impennata agli occhi degli altri. Una meraviglia.
È vero che quando si illustrano libri scritti da altri si narra una interpretazione del racconto, dando quasi vita a due storie? E quando scrivi e illustri i tuoi libri quante storie ci sono?
Che domanda immensa. Provo a rispondere. Quando si illustrano libri scritti da altri si fa una nostra lettura del testo.
La scrittura magnifica da illustrare è la poesia, è così sintetica da lasciare spazio a me che la illustro. Quei testi sono così belli da immaginare e poi illustrare, almeno per me. Non amo i testi descrittivi, perché se io quella bambina la leggo con i capelli rossi e lo scrittore mi obbliga a farla bionda divento un po’ triste e lo si percepisce dal mio disegno. Dobbiamo essere modesti e saper rifiutare un lavoro, se capiamo di non poterlo fare bene. Quindi sì, quando illustriamo il testo di un altro diamo vita a una delle tante storie che quel testo contiene.
Quando scrivo e illustro i miei libri so che ci sono infinite storie, e me ne accorgo quando incontro i miei lettori. Quel bambino che mi chiede perché in un libro ho narrato una cosa che in realtà non ho scritto mi fa pensare di aver fatto, forse, un buon lavoro, di aver dato luogo alle storie degli altri. E mi fa anche pensare che la maggior parte degli insegnanti che chiedono ai bambini di riassumere un testo stiano facendo un pessimo lavoro. Chi va fuori tema sta creando, è uno scrittore, chi non riassume un testo ma lo inventa è un attore e ha capito tutto della vita. Quasi sempre il loro voto scolastico è insufficiente.

Come nascono i tuoi personaggi fantastici?
Non lo so, me lo chiedo sempre. È un mistero. La mia testa è sempre troppo piena di idee, di cose. E disegno continuamente. Odio il computer perché mi tiene le mani impegnate, adoro il telefono perché mentre parlo nascono i miei personaggi. Non smetto mai di disegnare, e mentre disegno loro prendono vita. A volte è una vita semplice, è quella immagine lì, unica. A volte è una vita complessa, un inizio appunto. Lì mi entusiasmo, voglio gridare quel messaggio, e in un libro lo posso fare. Si tratta di una passione precipitosa, quasi ingestibile.
È la bellezza di un mestiere che mestiere non è perché si reinventa da solo ogni giorno. Loro, i personaggi, mi guidano per mano, li sogno, li vedo all’interno dei quadri antichi. Un’ombra di diavolo, una mano di bambino che tocca una foglia secca. E per strada, lo sguardo di quel cane che si sofferma nel mio. La corsa di quella ragazza che prende l’autobus al volo e che è così bella, ma non lo sa. Lì nasce tutto. Ed è irrefrenabile l’esigenza di dipingere, di scrivere, di cantare o suonare. Di esprimere questo strano mondo tempestoso e stupendo.
Nel 2014 hai pubblicato il libro “Cari Estinti. Venti specie animali estinte raccontano l’uomo che le ha fatte sparire”. Argomento di grande attualità se si pensa al recente disastro ambientale in Australia
Purtroppo sì. Ogni mio tema è in realtà molto attuale, perché i miei libri, come i miei quadri, nascono quasi sempre dall’esigenza di gridare al mondo ciò che vedo e che non accetto, ciò che di meraviglioso potremmo perdere. Abbiamo tanto e ce ne accorgiamo solo quando sparisce, questo è il maggior difetto dell’essere umano.
Il mio lavoro di arteterapia è incentrato, in gran parte, sul mostrare ai miei pazienti tutte le cose che possiedono e che sono sempre troppe. Le persone oggi sono viziate, vedono solo la mancanza. Se hanno una macchina piccola la vogliono grande, se hanno un orologio che funziona bene sperano di poterne comprare un altro di maggior valore. Non c’è motivo, viviamo bene con pochissimo e la consapevolezza di questo ci fa vivere felici.
Se riuscissimo a rinunciare agli oggetti superflui, allora non accadrebbe il disastro ambientale che vediamo oggi. Volere di più ci fa scegliere il mestiere sbagliato, quello che ci fa guadagnare di più e che ci fa ammalare di stenti perché non è il lavoro sognato fin da piccoli, ma che ci hanno detto non essere abbastanza dignitoso, correttamente remunerativo. E siamo infelici nei nostri giorni e nelle nostre ore, nel presente della nostra esistenza, che è tutto ciò che possediamo perché il passato è passato e il futuro non sappiamo se c’è.