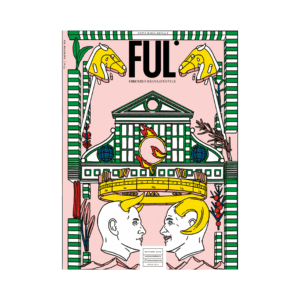Martedì 27 maggio, alla Galleria Biagiotti in via delle Belle Donne 39 a Firenze, è stata inaugurata la mostra Mnemonic City a cura del collettivo Magma. È lì che ho incontrato Anna Capolupo; sedute sulle scale della sala interna della galleria, davanti al suo quadro, abbiamo parlato di colore, viaggi, antiche tabaccaie, Berlino e Firenze, di fotografia e pittura, per giungere infine a dare una definizione ai suoi quadri: fotografie emozionali.
Martedì 27 maggio, alla Galleria Biagiotti in via delle Belle Donne 39 a Firenze, è stata inaugurata la mostra Mnemonic City a cura del collettivo Magma. È lì che ho incontrato Anna Capolupo; sedute sulle scale della sala interna della galleria, davanti al suo quadro, abbiamo parlato di colore, viaggi, antiche tabaccaie, Berlino e Firenze, di fotografia e pittura, per giungere infine a dare una definizione ai suoi quadri: fotografie emozionali.
Anna, qual è stato il tuo primo approccio al colore?
«Ho iniziato a dipingere in bianco e nero e solo dopo i primi anni di Accademia (ha studiato all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ndr), e ho cominciato ad usare il colore lì dove volevo il fuoco del quadro, il punto da cui per me parte tutto il resto. Un po’come nel film Schindlers’s List: dopo tutto il girato in bianco e nero appare la ragazzina col cappotto rosso che rappresenta la speranza, la chiave del film».
Com’è nata l’esigenza di cominciare ad usare il colore? Ti ricordi un momento preciso?
«L’esigenza è nata da ciò che andavo a dipingere: che fosse natura o paesaggio urbano avevo necessità del colore. Berlino è il luogo dove questa voglia è emersa con forza: lì i muri, i treni, i murales sono colorati e quei colori che mi passavano intorno, in una città che di per sé è molto grigia e cupa, con poco sole erano la mia primavera ed io ho potuto fare a meno di dipingerla».
Come sei arrivata a Berlino?
«Mi sono diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Firenze e poi sono partita. Ho scelto Berlino, perché mi interessava il suo fermento, il suo fervore in quanto centro artistico europeo. Dopo un anno ho capito che non era la città che faceva per me, così ho deciso di tornare al Sud e mi sono trasferita a Catania. Ed è lì che il colore è esploso sulle mie tele, erano i luoghi che me lo imponevano: non potevo fare a meno di dipingere il blu del mare. Posso dire che l’esigenza di usare il colore è più legata alla natura di ciò che dipingo più che ad una mia volontà: è quasi un’imposizione dovuta».
Perché scegli spesso come soggetto dei tuoi quadri paesaggi urbani di grandi città? Cos’è che ti attrae?
«Penso che l’urbano sia il tempo di cui faccio parte e di cui posso parlare. Nasce sicuramente per curiosità: vengo da un paesino di campagna in Calabria e quindi, soprattutto da ragazzina, la città rappresentava qualcosa di misterioso e lontano. Adesso i paesaggi urbani sono diventati il mio tempo, e non potrei parlare d’altro».
Esiste un criterio in base al quale scegli un determinato luogo?
 «Sicuramente è legato all’emotività, a ciò che un posto mi trasmette quando sono lì. Esistono però dei paesaggi ricorrenti nei miei quadri: ho dipinto molte stazioni (Torino, Firenze, Berlino), porti (quello di Catania) e questo non per le sensazioni che mi trasmettevano, ma per il loro significato che secondo me hanno. Stazioni e porti sono punti importanti e particolari di una città: rappresentano luoghi di passaggio, dove le persone si scambiano senza fermarsi mai. Tornando alla domanda, quindi direi che la scelta del luogo a volte è legata a ciò che mi trasmette, altre volte a ciò che ci vedo. Di base però c’è sempre la volontà di voler catturare un momento preciso, tentare di fermare il tempo».
«Sicuramente è legato all’emotività, a ciò che un posto mi trasmette quando sono lì. Esistono però dei paesaggi ricorrenti nei miei quadri: ho dipinto molte stazioni (Torino, Firenze, Berlino), porti (quello di Catania) e questo non per le sensazioni che mi trasmettevano, ma per il loro significato che secondo me hanno. Stazioni e porti sono punti importanti e particolari di una città: rappresentano luoghi di passaggio, dove le persone si scambiano senza fermarsi mai. Tornando alla domanda, quindi direi che la scelta del luogo a volte è legata a ciò che mi trasmette, altre volte a ciò che ci vedo. Di base però c’è sempre la volontà di voler catturare un momento preciso, tentare di fermare il tempo».
Nei tuoi quadri difficilmente appaiano delle persone, sebbene rappresentino prevalentemente paesaggi propri dell’uomo. Qual è la ragione di questa scelta?
«Negli ultimi anni ho abbandonato un po’ la rappresentazione diretta delle figure umane. Credo però di evocare l’uomo ogni volta che dipingo una città: non ritraggo mai qualcosa che non sia stato modificato o creato dall’essere umano, quindi in realtà sto raccontando la vita delle persone, senza il bisogno di fermarmi su un individuo particolare. Vorrei che tramite i miei quadri si percepisse la rappresentazione collettiva dell’esistenza sociale contemporanea e non quella di una singola persona. Credo che in quello che faccio emerga l’esistenza dell’uomo, la sua costante e imponente presenza e si intuisca come modifica lo spazio, come lo usa, quali sono i legami che ha con un determinato spazio e che tipo di memoria crea. Nei miei ultimi lavori che saranno esposti a Torino dal 5 giugno alla Burning Giraffe Art Gallery, ciò che si vede sono zone della periferia di Torino, prevalentemente aree industriali che erano state abbandonate e adesso sono state riqualificate, trasformandole in piazze, creando nuovi spazi sociali e di vita. Luoghi appartenenti alla memoria collettiva che continuano ad essere presenti nell’esistenza, in altre forme, con altri scopi».
Qual è la tecnica pittorica che usi prevalentemente?
«Dipingo su carta incollata su tela e uso colori ad acqua, acrilici, gessetti, pennarelli: una tecnica mista».
Ci sono degli autori che più di altri hanno segnato il tuo percorso?
«Diciamo che ho dei maestri classici, accademici che vanno da Caravaggio ai fiamminghi fino a Bacon. Però sono le persone con cui ho lavorato, quelle che mi hanno realmente ispirato e fatto crescere. Uno dei miei professori nei mesi estivi portava un gruppo di studenti a dipingere in un’ex tabaccaia in Mugello ed è lì che ho iniziato veramente a crescere artisticamente. Si creavano meccanismi virtuosi, grazie ai quali guardavi i tuoi compagni e ti lasciavi ispirare dal loro lavoro, dalla tecnica che utilizzava uno e dall’uso del colore di un altro: ho trovato input molto forti. Diciamo che i maestri classici mi hanno fatto sognare, mentre per la parte pratica le persone che avevo a fianco sono quelle che mi hanno fatta cambiare di più».
L’impressione che ho avuto guardando i tuoi quadri è quella di essere davanti a “fotografie emozionali”. Dove finisce la rappresentazione della realtà ed inizia la tua emotività?
«Diciamo che la mia alleata e nemica è sempre la fotografia, perché non dipingo dal vero, ma lavoro in studio: le foto per me sono fondamentali. Però è vero, esiste un punto reale, un momento in cui non voglio più vedere la fotografia, ma voglio ricordarmi le emozioni provate quando ero lì. E spesso mi capita di cancellare e ricominciare, cercando di focalizzare la fotografia e l’emozione e farne una sintesi mia personale. Lo scopo è riuscire ad identificarmi con sensazioni che neanche io conosco, ma le cerco dentro di me e nel luogo che sto dipingendo. Via via che dipingo scopro le emozioni nascoste e il quadro prende forma. Percepisco sempre il momento del distacco che ad un certo punto ho dalla fotografia e credo che questo sia il ruolo della pittura, che altrimenti sarebbe una qualcosa di semplicemente rappresentativo e muto. Sono convinta, non me ne vogliano i fotografi, che la pittura sia più forte della fotografia: viaggia su un altro livello emozionale, trascende profondamente il reale e a un certo punto la realtà non esiste più, hai solo visione».
MARTA PINTUS