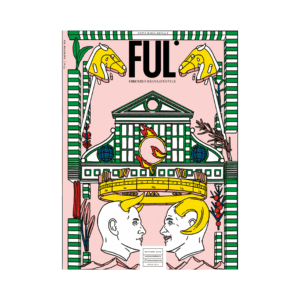La capitale argentina vista attraverso i suoi autobus da un fotografo fiorentino.

Sono un fiorentino figlio di argentini e ho vissuto parte della mia infanzia a Buenos Aires. Per un lungo periodo non vi ho fatto ritorno fino a quando, nel 2011, all’età di ventisei anni, mi sono trasferito lì per dieci mesi. Era da un paio d’anni che ero entrato in contatto con la fotografia e nel ripercorrere la città portavo spesso con me una camera analogica.
Quei mesi sono stati un percorso di riscoperta: i ricordi del passato si mischiavano con la fascinazione che provavo vedendo quella metropoli immensa, quel mostro che è Buenos Aires fatto dalla mescolanza di varie classi sociali, un crisol de culturas nato dalle numerose immigrazioni che si sono susseguite nel tempo. Quelle europee, all’inizio del Novecento, che hanno interessato italiani, spagnoli, tedeschi, polacchi, francesi e quelle dai paesi limitrofi Bolivia e Paraguay, fino alle ultime più recenti dal Venezuela e dall’Africa. Di questa mescolanza mi sono innamorato e in parte mi sono riconosciuto.

Arrivando da Firenze, le dimensioni della capitale argentina mi sembravano infinite. Con il passare del tempo scoprivo i quartieri della città, ognuno come autonomo dagli altri, ognuno con un’indole differente e come la somma di queste variegate personalità ne formassero il carattere schizofrenico.
Nell’architettura vedevo il passaggio delle epoche e delle varie fasi politico-economiche. I bellissimi edifici art déco, costruiti nel periodo d’oro di Buenos Aires, coperti nei piani bassi dalle coloratissime marquesinas – le insegne e i cartelli pubblicitari dei negozi – erano affiancati da palazzi di dieci, quindici piani costruiti durante il boom edilizio degli anni ’90. Questo paesaggio difforme crea un immaginario di eterni contrasti, disarmonico e alle volte anche disturbante ma nel quale si può vedere l’impronta del passaggio dei tempi, che lascia in ogni strada, marciapiede o angolo, la traccia di una storia. Un luogo in cui le varie storie si sommano in un’unica grande icona e in cui vedevo proprio quello che a Firenze non c’era, o meglio, esattamente la direzione opposta che stava prendendo: città vetrina, rileccata e ridipinta, più simile a un parco tematico, dove il passato veniva ripresentato sotto forma di artefatto e il futuro non ha spazio per svilupparsi.
Buenos Aires, invece, sentivo che aveva un’anima, una città alla quale ci si rivolge come a una persona, instaurando un complesso rapporto di amore e odio, proprio come accade con un familiare.

Scoprii che uno degli ambienti che più mi piaceva fotografare erano gli autobus. Lì dentro mi sentivo al sicuro. Il flusso costante di passeggeri e il susseguirsi di paesaggi al di fuori del finestrino mi mettevano all’interno di un mondo in continuo cambiamento e di forte inspirazione. Così cominciai a costruire questo progetto fotografico. Avere con me la macchina fotografica faceva sì che il viaggio – anche se spesso era un tragitto che avevo percorso più volte – diventasse unico. Il mio sguardo era sempre attento, quando vedevo un soggetto interessante si formava dentro di me una sensazione di tensione, nel dover decidere di puntare la camera a distanza ravvicinata su una persona che si trovava a poco meno di un metro. A volte scattavo in maniera automatica, senza nessun freno, altre volte passavano minuti prima che mi decidessi a farlo, altre ancora facevo passare così tanto tempo che il soggetto andava via e io me ne pentivo.
È stata una grande scuola, il mio battesimo nella fotografia di strada. Questa sensazione di scomodità nasceva non solo per la paura di una possibile reazione dei passeggeri, ma anche perché ero cosciente che in qualche modo mi stavo approfittando di loro. Li usavo come marionette a loro insaputa, per diventare elementi di composizione e soggetti drammatici di una foto che mai avrebbero visto e della quale ignoravano di essere i protagonisti. Così ho dovuto fare un patto con me stesso, accettando di essere un “ladro di volti” e capendo che in realtà non ero io il principale artefice della fotografia: lo erano i soggetti e l’attimo in cui era stato eseguito lo scatto. Quell’attimo dove il movimento di paesaggi esterni, vista dai finestrini e persone in movimento componevano una foto che non avevo totalmente premeditato.

“Bondi” è il nome con cui a Buenos Aires viene chiamato, in Lunfardo – un argot spagnolo ricco di parole italiane – l’autobus. Si dice che l’autobus come mezzo di trasporto pubblico sia nato proprio qui, quando apparve per la prima volta negli anni ’20. Il bondi diventa, attraverso la somma delle immagini della vita che anima Buenos Aires durante le varie stagioni, un nuovo soggetto: un micro mondo dove 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, gli abitanti della capitale si incontrano, tutti insieme, ma ognuno nel suo percorso. I passeggeri, che viaggiano schiacciati come sardine nelle ore di punta, più distanti nelle ore notturne, compongono lo scenario corale e frammentato di quello sguardo. La visuale si alterna spostando il fuoco dell’obiettivo da dentro a fuori del veicolo. Attraverso i finestrini vediamo passare la Capital con i suoi quartieri, abitanti, piazze e strade. E ancora, rivolgendo lo sguardo al suo interno osserviamo i passeggeri.
Nel 2016 sono tornato a Buenos Aires per rimanere due anni questa volta. La macchina fotografica l’ho usata meno, ormai sentivo che la città era una parte di me e aveva perso quell’innocenza e quel fascino che si percepiscono quando si entra in contatto con qualcosa di nuovo. Non avevo più la necessità di relazionarmici attraverso una lente, mi sentivo soltanto uno in più dei 15 milioni di persone che la abitano, uno dei passeggeri del bondi, come quelli che in passato avevo fotografato.
Testo e foto di Manuel Berisso
IG: @manuelberisso