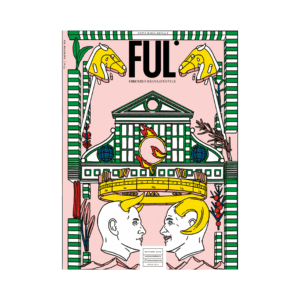C’è un modo di dire, tutto toscano, che suona letteralmente così:
“Fritte son buone anche le ciabatte”. A voler dire, fuor di metafora (colorita, ovviamente), che quel tipo di preparazione – con panatura, uova e cottura in Extravergine (a temperatura adeguata per non impregnare d’olio né lasciar crudo l’interno) – è in grado di valorizzare anche una materia prima alimentare non particolarmente pregiata.
Bene: prendendo per buona la premessa (basta provare: e si conteranno sulla punta delle dita quanti devono ancora farlo), ne deriva una considerazione immediata. Che affidiamo a un’altra esclamazione: “Figurarsi quanto sia sopraffino il risultato quando, invece, gli ingredienti di partenza sono già gustosi di per sé”. E’ il caso del piatto che proponiamo oggi come “soggetto” al quale dedicare un abbinamento “in salsa” birraria: il cosiddetto “fritto dell’aia”, voce tipica della tradizione di un po’ tutte le province e gli angoli della nostra regione, che allude a una pietanza polifonica, nella quale a cantare, ciascuno con la propria inflessione sensoriale, sono coristi di varia e diversa natura, tutti accomunati dall’appartenenza al costume contadino. Si va dalle carni (pollo, tacchino e coniglio in primis), alle verdure (patate, carciofi, carote, zucca e zucchine coi loro fiori, melanzane e cavolo di stagione, magari cipolle e porri), per includere anche vegetali aromatici, come le foglie di salvia.
Quel che ne esce è un boccone composito e ricco, nel quale – sotto il profilo della sostanza – alle proteine delle carni e dell’uovo si affiancano i grassi dell’uovo medesimo e dell’Extravergine, nonché i carboidrati del pangrattato e delle “pommes de terre”; mentre la “lente” gusto-olfattiva ne rileverà, oltre allo slancio odoroso connaturato ai mattoncini con cui si sta costruendo il nostro pasto, una coabitazione tra componenti neutro-morbide (le citate polpe animali e le patate), eventuali escursioni propriamente dolci (la zucca, la cipolla, le carote, il cavolo) e il loro corrispettivo speculare – ovvero qualche venatura amaricante – apportata da carciofi e zucchine. Ecco, tenendo presenti proprio le possibili vibrazioni amaricanti, unite ad altri due “fondamentali” come l’acidità apportata dalla frittura stessa e la sapidità affidata alla “mano” del cuciniere, va da sé che la birra di cui siamo in cerca dovrà, punto primo, non propendere verso il “bitter” del luppolo, ma più preferibilmente verso gentilezze gustative di traiettoria vagamente abboccata.
E magari avvalersi lei pure di una certa curvatura acidula, con cui elidere quella del morso e con cui operare un’efficace gestione della massa lipidica, provvedendo a mantenere in ordine il cavo orale. Altre frecce auspicabili all’arco della nostra pinta? Buon ventaglio di profumi e corpo non eccessivo, per giocare alla pari con la “forchetta”. Mettiamo insieme le tessere del puzzle e quale identikit componiamo? Quello di una Weissbier bavarese… Tipologia di cui suggeriamo alcune (tra le non molte) interpretazioni toscane: la “Weizen” (al farro) de La Petrognola (Colognola, Lucca); la “Wai.Zen” di Badalà (Montemurlo, Prato) e anche, in versione scura (Dunkelweizen) la “Odiosa”, dell’Opificio Birrario (Lavoria, Pisa).
Simone Cantoni