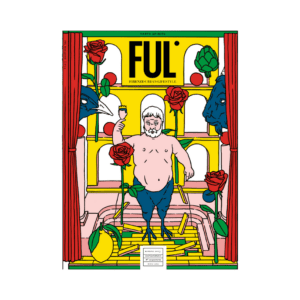Firenze, 9 maggio 1938, ore 13:45. Adolf Hitler è giunto alla tappa finale del suo Grand tour italiano. È nel capoluogo toscano che verrà sancito il trattato d’alleanza del Nazismo con il Fascismo. L’antifascista Eugenio Montale scriverà una poesia sul quel funesto giorno.
Hitler scende dal treno diretto da Roma, al binario 16, come un comunissimo turista. La stazione di Santa Maria Novella è un tripudio di bandiere gigliate, croci uncinate, stemmi sabaudi e fasci littori. La gente si accalca per poter intravedere l’ospite in tutto il suo splendore luciferino. Tra questi è presente anche il poeta Eugenio Montale. O così sembra, a giudicare dalla sua poesia La primavera hitleriana, pubblicata nel 1946 e poi confluita nella silloge La bufera e altro (1956). Il dittatore attraversa fulmineamente il corso Regina Elena, oggi Corso Italia, mentre i militi si sgolano in festanti alalà. Montale sogguarda meditabondo la grottesca parata. È come se la città del fiore si fosse tramutata nel Pandemonio.
Hitler non era mai stato a Firenze, ma aveva spesso vagheggiato le sue eccellenze pittoriche sui suoi manuali d’arte medievale e rinascimentale. Benito Mussolini lo accompagna, nel corso di tutta la giornata, al Giardino di Boboli, a Palazzo Pitti, alla Galleria degli Uffizi, a Palazzo Vecchio, come una guida turistica. Di fronte alle opere più sublimi, l’austriaco emette un gorgogliamento gutturale di pura soddisfazione. Attraversa il corridoio vasariano mormorando con eccitazione «Michelangelo, Michelangelo…».
Mussolini invece non nasconde il suo totale disinteresse di fronte alla pittura, osservando i quadri come se si trovasse di fronte ad un muro bianco. Viene allestita in loro onore un’opera al Teatro Comunale, il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. Scelta singolare, dal momento che al termine della storia è presente l’uccisione un tiranno. Ciononostante, il melodramma è particolarmente apprezzato dal gerarca nazista Joseph Goebbels, il quale scrive nel suo diario che si è trattata di «un’eccellente esecuzione».
Anche le vetrine del centro ossequiano il Führer. Sono semivuote, prosciugate dalle recenti sanzioni per l’invasione dell’Etiopia (1935-36), ma quel poco che è rimasto è pervaso dallo spirito militarista consono al clima prebellico. Compaiono in esse cannoni e armi-giocattolo. La porta della Macelleria del Beccaio è serrata, anche lui ha deciso di chiudere per festeggiare la visita. Solitamente, nelle sue vetrine esponeva capretti uccisi con il muso ornato di bacche. La ferocia si insinua nell’inoffensività del giocattolo, nella macabra esibizione dei cadaveri infiorati. I bottegai preannunciano il prossimo spargimento di sangue innocente nel loro ignaro culto della strage.
L’ideologia nazifascista si perpetua grazie all’acquiescenza, ogni singola azione ha la sua dose di responsabilità e complicità. Consapevole di questo aspetto, il cardinale Elio dalla Costa ha sbarrato tutti gli ingressi delle chiese fiorentine, cattedrale di Santa Maria del Fiore e basilica di Santa Croce comprese. Hitler e Mussolini non accederanno a nessun luogo di culto. Dichiara con audacia che non venererà «altre croci che non quella di Cristo», con ovvio riferimento alla blasfema svastica. Anche Montale sostiene l’antifascismo, subendone le conseguenze. A distanza di pochi mesi dalla venuta del cancelliere, gli verrà revocato l’incarico di direttore del Gabinetto Vieusseux poiché non iscritto al partito.
Una volta sfrecciata via l’auto del nazista, il poeta inizia ad interrogarsi. «Tutto per nulla, dunque?». Secoli di civiltà e di cultura non sono riusciti ad impedire la guerra mondiale. All’improvviso riaffiora nella sua memoria la figura di Irma Brandeis, la sua amata dagli occhi d’acciaio. Era stata costretta al rimpatrio negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni razziali, era di origine semitica. Esuma il loro addio definitivo che ebbe luogo nella medesima città. Il cielo s’illuminava di fuochi d’artificio per la festa di San Giovanni, patrono di Firenze. Al ricordo dello spettacolo pirotecnico si unisce la suggestiva visione di una cometa nei gelidi cieli del Nordamerica, presagio di una possibilità salvifica nella cupezza del futuro.
Ripensa alle segrete promesse che si fecero, e a come le mani di Irma sembrassero mirabilmente tramutarsi in girasoli, pronti a voltarsi verso la loro sorgente di vita. Aveva scelto di rinominarla Clizia nei suoi componimenti, recuperando il nome da una fabula mitologica delle Metamorfosi. Nel poema ovidiano la ninfa Clizia, abbandonata dal dio Sole, decide di non nutrirsi più per nove giorni se non di lacrime e rugiada, e di attendere il ritorno dell’amato sulla nuda terra. Le sue membra finiranno per aderire al suolo. Diverrà un eliotropio, ovvero una pianta, preservando il suo tribolato amore sebbene mutata nell’aspetto («mutataque servat amorem»).
Scende la sera. Sconvolto e affranto, il poeta scruta gli inquietanti fenomeni che l’arrivo del Führer sembra aver causato. Un brulicante sciame di falene bianche si addensa sopra gli argini dell’Arno. Molte tra di esse precipitano al suolo, folgorate dalla luce dei proiettori. Generano per terra uno strato che scricchiola sotto i piedi come i cristalli di zucchero quando vengono calpestati. Ed ecco che, di fronte alla profezia dello sterminio sotto forma di mortifera nevicata di falene, la poesia di Montale raggiunge il suo zenit lirico. La solare Clizia, colei che ama con la stessa intensità nonostante le vicende personali e storiche («il non mutato amor mutata serba», come forse scrisse Dante in un suo sonetto di dubbia attribuzione), dovrà farsi garante della salvezza di tutti gli uomini, divenendo allegoria ultraterrena dell’imperitura speranza. La sua luce dovrà congiungersi con la luce assoluta del Divino, allo stesso modo di Beatrice nel Paradiso. Nella sua sfavillante sublimazione, nel suo catartico sacrificio di matrice cristologica, si rigenererà divampante come l’araba fenice. Grazie a lei, la poesia potrà caricarsi di un messaggio medianico, opponendosi al delirio diabolico dell’incombente apocalisse bellica.
Il Duce accompagna il Führer alla stazione. Si congedano con una tanto solenne quanto vanagloriosa promessa: «Oramai nessuna forza potrà separarci». Una lacrima riga il viso del cancelliere. Il treno si dirige verso Berlino, la vettura di Mussolini si avvia verso Roma. Montale ascolta lo scampanio che commiata i nazifascisti, è scoccata la mezzanotte da pochi minuti. Forse i rintocchi della Martinella già si confondono con un suono celeste che predice la vittoria sul male assoluto. Dopodiché volge lo sguardo ai ghiaiosi greti dell’Arno. Nella tenebra della notte immagina il sopraggiungere di un’alba fresca e luminosa, scevra del sinistro sfarfallio. Inizia a modulare nella mente i versi di una poesia, nella chimera che la letteratura possa annichilire l’orrore mediante la sua radiosa lungimiranza.
La primavera hitleriana, Eugenio Montale
Folta la nuvola bianca delle falene impazzite
turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette,
stende a terra una coltre su cui scricchia
come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona
ora il gelo notturno che capiva
nelle cave segrete della stagione morta,
negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai.
Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale
tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso
e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito,
si sono chiuse le vetrine, povere
e inoffensive benché armate anch’esse
di cannoni e giocattoli di guerra,
ha sprangato il beccaio che infiorava
di bacche il muso dei capretti uccisi,
la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue
s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate,
di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere
le sponde e più nessuno è incolpevole.
Tutto per nulla, dunque? – e le candele
romane, a San Giovanni, che sbiancavano lente
l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii
forti come un battesimo nella lugubre attesa
dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando
sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi
gli angeli di Tobia, i sette, la semina
dell’avvenire) e gli eliotropi nati
dalle tue mani – tutto arso e succhiato
da un polline che stride come il fuoco
e ha punte di sinibbio…
Oh la piagata
primavera è pur festa se raggela
in morte questa morte! Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu
che il non mutato amor mutata serbi,
fino a che il cieco sole che in te porti
si abbàcini nell’Altro e si distrugga
in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi
che salutano i mostri nella sera
della loro tregenda, si confondono già
col suono che slegato dal cielo, scende, vince –
col respiro di un’alba che domani per tutti
si riaffacci, bianca ma senz’ali
di raccapriccio, ai greti arsi del sud…