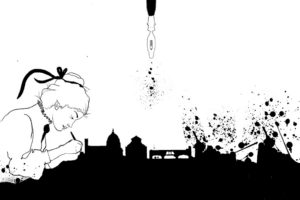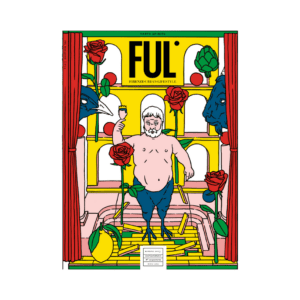“È la tempestosa leggiadria del terrore: dalle serpi lampeggia un cupreo bagliore acceso in quei loro inestricabili avvolgimenti, e fa intorno come un vibrante alone, mobile specchio di tutta la beltà e tutto il terrore di quel capo: un volto di donna con viperei crini, che nella morte contempla il cielo da quelle umide rocce.”
Percy Bysshe Shelley, On the Medusa of Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery, 1819.
Shelley non sapeva di tenere a battesimo un intero orizzonte immaginativo del romanticismo, dinanzi alla Medusa fiamminga degli Uffizi. Un fiume carsico veniva in superficie. La bellezza si accompagna all’orrore, spesso in un groviglio inscindibile come quelle ciocche di serpente. Bellezza è paura. Lo avrebbe testimoniato anche Stendhal, sempre – significativamente – a Firenze, quando a sua volta provò a descrivere la vertigine affannosa che lo colse uscito da Santa Croce, la malia che da allora ha preso il suo nome. «Ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere».
Più genericamente, l’arte sa sconvolgere, pure nelle sue manifestazioni più limpide e serene. Ma c’è un altro livello. Spesso quella perfezione formale e quel pathos si veicolano a noi attraverso immagini e concetti che non hanno niente di puro o sublime in sé, e che anzi attingono ai nodi più oscuri e feroci della nostra vita, echi preistorici che si fanno marmo o pittura e che pure continuano a raccontare quello che, nella vita di tutti i giorni, non vorremmo incontrare mai: scalpi recisi, gole recise, stupri, urla raggelate. Basta aggirarsi in Piazza della Signoria per muoversi tra il trionfo d’una testa decapitata e il rapimento forzato d’una donna. Su tutto ciò svetta la torre da cui fu gettato Rinaldo Pazzi dopo la congiura contro Lorenzo e Giuliano, impiccato e squarciato come Giuda.

È facile ricorrere a catarsi e sublimazione, e altrettanto facile di recente brandire lo sdegno di chi vorrebbe applicare a tutto questo il correttismo d’un filtro morale e censorio. Verità più basilare e sporca è che tutto questo continua ad attrarci come un riflesso oscuro, sghembo, si appella a gangli che portiamo comunque dentro. E non è casuale che tutto questo converga, ancora una volta in legame con Firenze, in una delle grandi figure archetipiche dell’immaginario contemporaneo, il Dottor Lecter dei romanzi di Thomas Harris e dei film e serie di Mann, Demme, Scott, Fuller, lo psichiatra cannibale e artista poligrafo che ha avuto il volto di Hopkins, Mikkelsen, Cox. Per arrivare ai suoi banchetti di carne umana accompagnati da Bach, mentre dalla finestra si può rimirare Palazzo Vecchio, occorre però un lungo passo indietro.
Per il suo peso di taboo e l’eco della sua perenne possibilità ancestrale, da sempre il cannibalismo nell’arte e nel pensiero ha rappresentato una soglia che ci riporta improvvisamente in un passato che vorremmo dimenticare e superare. Un pedale schiacciato perché la macchina umana schizzi a tutta velocità e torni così a imitare la ferocia delle bestie. “Vorrei che mi bastasse l’animo e il furore / a tagliare il tuo corpo e mangiarlo crudo, per quello che mi hai fatto” minaccia Achille a Ettore morente. Più ancora, il Polifemo dell’Odissea trova nel divorare i marinai di Ulisse il suggello definitivo di quanto già palesato dal suo irridere le leggi dell’ospitalità. Siamo dinanzi a qualcuno che è fuori dal consorzio umano, dalle leggi che faticosamente abbiamo imposto ai nostri istinti. “Con un balzo sui miei compagni le mani gettava […] non lasciò indietro/ né interiora, né carni, né ossa o midollo”.
Per Dante la matta bestialitade dei peccatori peggiori si incarna nel fiero pasto di Ugolino, e così via. Quello che si ripete ancora e ancora, nelle leggende su Orchi e Mannari, è quanto Kipling sintetizzò nel titolo di un suo racconto, il Marchio della Bestia.

C’è però una svolta, che coincide col diffondersi della rete urbana contemporanea nel diciannovesimo secolo. La Bestia si nasconde in modo nuovo, non è più stanabile come il lupo travestito da nonna in Cappuccetto Rosso. Una trasformazione radicale, immortalata dall’intuizione di Stevenson che non fece del suo Hyde un bruto scimmiesco ma solo un uomo da cui promana qualcosa di strano e repellente, al netto delle tante banalizzazioni cinematografiche: “al primo vagito di questa nuova vita ebbi coscienza di essere più malvagio, dieci volte più malvagio, incatenato come uno schiavo al mio male originario. E quel pensiero mi inebriò come una coppa di vino”.
Tale assoluta coincidenza prosegue ancora col Norman Bates di Psycho, come notò il “re” dell’horror Stephen King: «Per il mondo che l’osserva, Norman è del tutto normale, sembra un così bravo ragazzo. Ma Norman è il Licantropo. Solo che invece di farsi crescere il pelame, per trasformarsi si mette addosso mutandoni, sottane e vestito della madre morta. E invece di mordere gli ospiti, li prende a coltellate. Noi vediamo che Norman è il Licantropo solo esteriormente, ma ci coglie lo sgradevole sospetto che interiormente egli sia Licantropo sempre». Lo stadio definitivo di tale evoluzione, di questo avvicinarsi progressivo alla vita civile, è proprio Lecter. Anziché essere un bruto, schiavo dei suoi impulsi più violenti, egli per primo è un medico dell’Es freudiano. Anziché ignorare l’ospitalità, da squisito anfitrione tiene banchetti eleganti nei quali serve i suoi stessi amici “per cena”, accompagnati da un “buon Amarone” (il film corresse in “Chianti”, e già questo porta a Firenze e al suo peso nell’immaginario del turismo medio-colto). La rotazione è completa.
“Non era uno sbandato, non aveva precedenti penali. Non era poco intelligente e afflitto da piccole manie, come la maggior parte dei sociopatici. Non è privo di sensibilità. Non sanno come definirlo. Le pulsazioni non sono mai salite oltre 85. Anche quando le ha strappato la lingua”. Alla sua prima comparsa in cella quest’uomo piccolo e ordinato sfoglia Le Grand Dictionnaire de Cuisine di Alexandre Dumas, e l’edizione italiana di Vogue. “Per un secondo vertiginoso Clarice ebbe la sensazione che quello sguardo emettesse un ronzio. In realtà sentiva soltanto il rombo del proprio sangue.” Come una gazzella che fissi un leone nell’erba. E alla parete è affisso un disegno che permette di citare con malizia Camera con vista di Forster e la città toscana: «Quella sopra il lavabo è una città europea?» «È Firenze. Ci sono il Palazzo della Signoria e il duomo, visti dal Belvedere.» «Ha riprodotto tutti i dettagli a memoria?» «Io ho la memoria al posto della vista, agente Starling.»
Ed è proprio a Firenze che l’assassino seriale riparerà dopo l’evasione, per una elezione che costituisce a sua volta un ritorno. Perché, come verrà scoperto nel romanzo successivo di Harris, Lecter non è altri che il Mostro di Firenze stesso, e il suo amore per l’arte l’anello mancante che permette finalmente di cogliere il senso ultimo di quelle macellazioni in campagna avvenute anni prima.

“Eccolo: un manifesto picchiettato dalle mosche e sgualcito dalla pioggia, con la riproduzione della Primavera del Botticelli. Il quadro originale era alle sue spalle, nella Galleria degli Uffizi. La Primavera. La ninfa inghirlandata sulla destra, il seno esposto, con i fiori che le uscivano dalla bocca, e il pallido Zefiro che soffiava dal bosco. Ecco. L’immagine della ragazza morta sull’erba, con i fiori di campo sulle labbra. Avevano pensato che i fiori fossero finiti lì casualmente, dopo essersi staccati dal prato mentre il Mostro trascinava il corpo lontano dalla macchina”. Quanto noi ammiriamo dietro una teca, egli lo prende terribilmente sul serio, e fa riaccadere. Come ogni artista, riecheggia il potere alle sorgenti ambigue del creato. “Il male è soltanto distruttivo? Se c’è un Dio, si diverte, agente Starling. Febbre tifoide e cigni provengono tutti dalla stessa fonte. Dio uccide continuamente”.
Ma il passaggio più metaletterario, alla radice del fascino che questa creazione narrativa ha saputo intercettare, sta in uno scambio con la giovane agente che gli si rivolge per scovare un assassino di donne. “Che cosa fa, l’uomo che vuole catturare?” La risposta “Uccide” suscita nel mentore sorridente solo spallucce. “Desidera. Desiderare è nella sua natura”. Come tutti e ciascuno, sempre. Un ritratto dell’artista come assassino e della vittima come spettatore, e quel che più conta complice segreto. Lo sgomento e l’inquietudine suscitati in noi da un quadro o una scultura o un verso sono la sorpresa d’uno specchio rivelatore. Quel desiderio di mordere, lacerare, colpire, si annidano nella stessa tensione che può farci distogliere lo sguardo, che è come non smettere di guardare mai.
Foto di Jacopo Visani