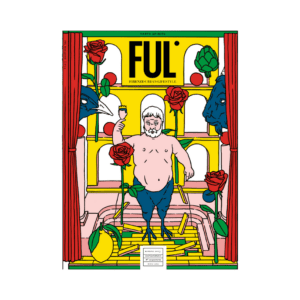Nel centenario della nascita, FUL celebra Don Lorenzo Milani con un breve profilo, per ricordare il prete laico fiorentino che con i suoi metodi didattici ha sfidato le autorità ecclesiastiche e scolastiche.
Il 20 giugno 2017, Francesco – il Papa venuto dalla “fine del mondo” – andò a Barbiana, un altro posto alla “fine del mondo”, e lassù alle pendici del Monte Giovi rese omaggio a Don Lorenzo Milani. Quest’ultimo poi non è stato ancora beatificato, però quella visita fu significativa. Come lo sarà quella del 27 maggio, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente alle celebrazioni per il centenario della nascita.
Un prete scomodo Don Lorenzo, ma ogni anno migliaia di persone vanno a visitare la parrocchia dove fu esiliato dalle gerarchie ecclesiastiche. Perché qui, per tutta risposta, fu eletta la comunità rurale a laboratorio per avviare un esperimento culturale e politico che ha contribuito a cambiare la storia pedagogica dell’Italia. E forse è per questo che le correnti conservatrici continuano ad attaccarlo, attribuendogli le colpe di un presunto malfunzionamento della scuola italiana, addirittura il precursore del Sessantotto con i suoi scritti.
Lorenzo Milani Comparini nasce a Firenze il 27 maggio del 1923 da una famiglia dell’alta borghesia e dopo il trasferimento a Milano studia arte all’Accademia di Brera. La famiglia torna a Firenze alla fine della Seconda Guerra Mondiale e Lorenzo a vent’anni, scoperta la vocazione durante un’operazione di restauro in una cappella, decise di entrare in seminario. Ma sarà sempre un pastore di anime sui generis, un prete laico, antiautoritario e graffiante verso una Chiesa che stava dalla parte dei ricchi e dei padroni.
Nel 1954, a causa di screzi con la Curia di Firenze – che lo riteneva troppo franco e poco cauto nei toni, nonché troppo vicino agli emarginati – fu spedito a Barbiana. Quella parrocchia sperduta del Comune di Vicchio serviva per toglierselo dai piedi, e invece è qui che il maestro compie il suo capolavoro di educatore.
La comunità di Barbiana è composta da poche centinaia di persone, un posto povero dove alla metà degli anni Cinquanta si vive ancora senza elettricità, senza riscaldamento e i bambini non vanno a scuola. E lui convince i contadini che devono mandare a studiare i loro figli – perché non siano più oppressi – nella scuola che lui stesso ha organizzato in canonica.

È una scuola poverissima, c’è un solo libro di testo; i ragazzi, a turno, leggevano la lezione e Don Lorenzo spiegava. Era una scuola diversa da tutte le altre: diversa negli orari, diversa nei contenuti, diversa nei metodi di insegnamento. Ma si studiano anche le lingue straniere e si commentano i fatti riportati dai giornali. Il suo metodo fu assolutamente innovativo e radicale. La scuola impegnava i ragazzi tutto il giorno, tutti i giorni dell’anno, dimostrando che anche i figli dei contadini poveri e con pochi strumenti possono emanciparsi. «Siete proprio come vi vogliono i padroni: servi, chiusi e sottomessi. Se il padrone conosce 1000 parole e tu ne conosci solo 100 sei destinato ad essere sempre servo» diceva. Il suo modello di scuola suscitò immediatamente molte critiche e ricevette attacchi, sia dal mondo della chiesa sia da quello laico. Pier Paolo Pasolini ne prese le difese e pure Indro Montanelli guardò con simpatia a quel “pretaccio”.
Don Milani rispose a queste critiche con l’opera Lettera a una professoressa – pubblicato nel maggio 1967, un mese prima della sua morte – in cui, insieme ai ragazzi della sua scuola, denunciò il sistema scolastico e il metodo didattico che favoriva l’istruzione delle classi più ricche, mentre permaneva la piaga dell’analfabetismo in gran parte del paese. Lettera a una professoressa divenne appunto uno dei testi di riferimento del movimento studentesco del ‘68.
Un anno prima, con una lunga lettera pubblicata su Rinascita, il settimanale del Partito Comunista Italiano, aveva sostenuto pure la difesa dell’obiezione di coscienza, all’epoca vietata in Italia, contro l’obbedienza cieca. In modo perentorio e definitivo scrive che l’obbedienza non è più una virtù, attirandosi le ire dei cappellani militari. Il 15 febbraio del 1966 si concluse a Roma un processo destinato a segnare la storia politica e culturale del nostro paese. In quel giorno, infatti, il prete di Barbiana venne processato e assolto per il reato di apologia e incitamento alla diserzione e alla disobbedienza civile. Poi fu condannato in appello, ma lui era già morto prima della sentenza di secondo grado.
Il 26 giugno del 1967, a soli 44 anni, si spegne a Firenze, sconfitto dal linfoma di Hodgkin, tumore diagnosticatagli qualche anno prima. Sarà tumulato – in abito talare e scarponi da montagna – proprio nel piccolo cimitero di Barbiana come da suo testamento.

Don Milani è un prete amato dai laici perché non è stato simbolo solo di una nuova esperienza didattica, ma anche di anti-autoritarismo e onestà intellettuale. E poi c’era l’impegno antifascista – «un fascista più dieci qualunquisti fanno undici fascisti» – di chi amava la Costituzione quanto il Vangelo. Merita di essere ricordata anche una sua presa di posizione calda tutt’oggi, quella contro “il merito”. Che “la meritocrazia” fosse un falso mito lui lo aveva già capito all’epoca, esplicitandolo con un’altra celebre frase: «non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diseguali». Ovviamente i giornalisti di destra l’avevano già bollato come “prete rosso”.
In conclusione, la lezione del prete di Barbiana è attualissima e nasce dalla convinzione che la cultura fosse necessaria per evolversi e aiutare gli ultimi a superare la rassegnazione. L’importanza e la forza delle parole per combattere i soprusi, il sapere come strumento di ricchezza morale e libertà.
Purtroppo oggi il suo “I care” – che contrapponeva al motto fascista “me ne frego” – sembra più distante, in una società improntata al vuoto culturale generato anche dei social network. Don Milani ci ha lasciato un’eredità morale e civile da tenere in vita e non da esporre come un santino.
Articolo di Francesco Sani e Valerio Grana