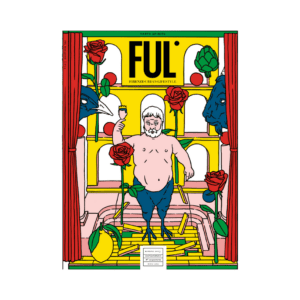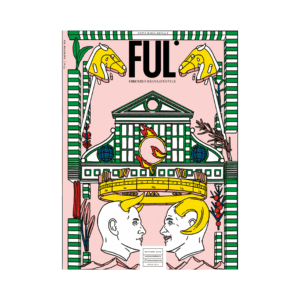Intervista alla fotografa Chiara Fossati di CESURA in occasione dell’uscita del suo libro che raccoglie immagini scattate negli anni Novanta durante i rave in Italia.
Chiara Fossati è una fotografa di Legnano, classe 1984; si è formata a Firenze allo Studio Fondazione Marangoni e a Londra, al Goldsmith College, dove ha ottenuto il master in Fotografia e Cultura Urbana. Oggi vive tra la sua casa di Milano e quella vicino Piacenza ed è membro di Cesura Publish, che è un collettivo di fotografi e una casa editrice, specializzata in pubblicazione di libri fotografici a edizione limitata.
WHATEVER è il primo libro di Chiara Fossati: si tratta della peculiare raccolta di fotografie analogiche del periodo della sua adolescenza, quando Chiara frequentava la scena rave e i free party, insieme di istanze politico esistenziali e ultima controcultura capace di unire migliaia di persone da tutto il mondo. Occupare edifici vuoti, suonare musica e ballare, tra azione diretta, neotribalismo e cyberpunk: nel principio di avventura è nata la fotografia di Chiara. WHATEVER è uno scrigno prezioso, che racconta in modo puro e semplice quegli anni, tra il 1998 e il 2005, di controtendenza e ribellione. Le immagini sono campi chiusi di forze in cromatismo bianco/nero, quasi pittorico.
“Ero un’adolescente in cerca di avventure e libertà” scrive Chiara, “ed è così che mi sono trovata al tramonto del movimento rave con una macchina fotografica appesa al collo. Questa è la storia della mia famiglia adottiva e il sogno comune di migliaia di bambini e bambine di vivere in un mondo non soggetto a regole o costrizioni. Ho trascorso sei anni della mia vita viaggiando nella mia Mercedes Benz del 1983 per incontrare i miei amici in fabbriche abbandonate e boschi isolati, seguendo le indicazioni telefonando ad un numero avuto da un amico di un amico. Tutto era possibile: c’erano muri di altoparlanti e strade fatte di furgoni e camion e la musica inarrestabile era ovunque. Una sola regola: non vendere e non consumare eroina. Ognuno poteva essere solo sé stesso, in quella casa temporanea che era la pista da ballo, dove si può dimostrare che è possibile vivere in una società diversa”.

L’evento presso ARTigliera è stato bellissimo. Lo spazio espositivo: un set di luci e fumi, che hanno reso l’esposizione delle immagini ancora più suggestiva. La presentazione è stata curata da Ninotchka (lo shop underground fiorentino di via dei Pandolfini), Chiara era sorridente e con la sua voce musicale, impreziosita da una erre moscia delicata, ha raccontato al pubblico il suo libro, in cui c’è tutto: i furgoni, i cani, i muri di casse, la verità enfatica dei gesti, la cerimonia delle sostanze, la danza, i piercing, gli abbracci, l’estetica post-industriale.
Oltre alle immagini fotografiche, nel libro ci sono testi appassionanti e accurati sulla cultura rave, approfondimenti storici e “la festa” intesa come rituale condivisibile da tutti in quanto abitanti del pianeta, che porta alla liberazione fisica e mentale attraverso la danza.
Mi collego via Skype con Chiara Fossati, che oggi si trova a Marsiglia, dove è occupata con il suo nuovo lavoro.
Chiara Fossati, fotografa. Puoi raccontare qualcosa di te?
Sono una fotografa, mi occupo esclusivamente di fotografia. Anzi, per quasi vent’anni ho fatto anche la cameriera. Quando ero ragazza molti miei amici fotografi cercavano di sbarcare il lunario facendo qualche lavoretto legato alla fotografia, come i fotografi di matrimoni, ecc… Io ho sempre odiato quel genere di cose, quindi mi sono detta che non era obbligatorio restare nel mondo della fotografia ad ogni costo: piuttosto che fare un lavoro dove la fotografia veniva fatta in quel modo, ho deciso di fare altro. Da cinque o sei anni, però, vivo di fotografia per come la amo: insegno Storia della Fotografia Contemporanea allo IED di Milano. Sono anche la studio manager di Paolo Ventura, un matto, noto artista pittore e fotografo, e insieme facciamo di tutto: scenografie e costumi per teatri importanti, mostre, collaborazioni con gallerie… è davvero molto divertente e stimolante.
Che cos’è la famiglia Cesura?
Cesura è un collettivo nato ufficialmente tredici anni fa. È stato fondato da Alex Majoli, che è un grandissimo fotografo, uno dei fotografi di Magnum: all’epoca, Alex cercava un posto dove creare un collettivo per lavorare con la fotografia vicino Milano; un giorno ha preso una piantina della città di Milano e col compasso ci ha disegnato sopra un cerchio (“…È andata proprio così!”, ride ndr) per trovare un luogo che fosse a un’ora di macchina dall’aeroporto di Linate, e ha trovato questo posto nelle campagne piacentine. Il progetto è iniziato come bottega artigiana: Majoli insegnava il lavoro ai ragazzi, che a loro volta imparavano e gli facevano da assistenti. Nel corso degli anni, gli assistenti hanno seguito il loro maestro e la realtà è cresciuta. Io sono arrivata lì quasi undici anni fa, e ci ho vissuto e lavorato più di tre anni, per poi occuparmi del mio percorso personale, pur rimanendo sempre legatissima ai ragazzi di Cesura.
Tre anni fa c’è stata poi una rivoluzione nell’asset di Cesura e mi hanno chiesto di tornare come fotografa, cosa che ho fatto: al momento, sono una dei diciassette fotografi del collettivo.
Cesura è una realtà unica nel mercato italiano e non solo: siamo un collettivo che fa moltissime cose diverse, siamo fotografi ma realizziamo anche libri, abbiamo la nostra casa editrice, abbiamo un laboratorio di stampa attivo anche per esterni, allestiamo mostre, facciamo curatela, facciamo masterclass e corsi. Abbiamo poi tantissimi stagisti, assistenti, ragazzi giovani a cui stiamo insegnando un mestiere. Per me stare a Cesura è stato come fare “il militare della fotografia”, imparando veramente tanto e di continuo, non come a scuola, dove hai l’orario da rispettare.




Perché la fotografia?
La fotografia perché fin da molto piccola ho capito che era il mezzo con cui riuscivo a esprimermi meglio e comunicare con il mondo. C’è un momento preciso in cui ho avuto un’epifania: ero al liceo artistico, avevamo una camera oscura dove passavo i pomeriggi, una volta ricordo che ho stampato una foto, sono uscita fuori dalla camera oscura a guardarla e in quel momento ho realizzato che quella fotografia era per me, esteticamente ed emotivamente, la cosa più vicina a quello che avevo provato nel momento in cui avevo scattato la foto. Lo so, è molto romantico (ride, ndr): ho capito che la fotografia era il mezzo che si avvicinava di più a quello che io volevo comunicare.
Che rapporto hai con la luce e il colore?
La luce per me è fondamentale. Nella mia fotografia scatto quasi sempre con luce naturale. Mi sono abituata a guardarla con attenzione, a saperla leggere. Anche a casa ho un’ossessione per i punti luce, ed ho bisogno di calori e intensità diverse. Il colore, poi, è fondamentale perché racconta tanto di una storia. In WHATEVER il bianco e nero però non è stato una scelta. Ero veramente piccolina, non avevo soldi: vivevo da sola a Firenze e scattavo, il bianco e nero potevo svilupparlo e stamparlo in camera oscura a scuola senza costi.

WHATEVER, il titolo del libro è sintomatico: scatti in bianco e nero di un’adolescente che testimonia il mondo rave anni Novanta. Raccontaci del tuo ultimo lavoro.
Il titolo del libro è stato per molto tempo Where here you in 99?, ma non convinceva Alex Majoli… io ho tatuato sulle nocche la parola “whatever”, lui quindi mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: «…Whatever!». E così è diventato il titolo definitivo, l’ho ripetuto sulla quarta di copertina tante volte, come fossero dei bassi, e te lo potrei tradurre con un franchissimo: stikazzi, le cose importanti nella vita sono davvero poche e dobbiamo dargli il giusto valore. E questo sintetizza forse anche il mio sguardo fotografico.
Ogni prima di copertina del libro è un pezzo unico: ci ha disegnato un pezzo il writer Click. Il design è stato curato dallo Studio Moretti Visani di Firenze e tra i testi all’interno ce n’è uno di Diego Marcon, giovanissimo e fortissimo artista contemporaneo: mi sono avvalsa di validi professionisti, che prima di tutto sono amici, da una vita.
Questo mio lavoro crea una distinzione con tutto quello che c’è stato dopo, perché, semplicemente, non è stato fatto con cognizione di causa. Ero un’adolescente quando ho scattato quelle foto, sapevo che avrei voluto fare la fotografa nella vita ma non mi ero ancora mai misurata seriamente con la fotografia, quindi non c’era alcuna attitudine progettuale nel porsi. Io facevo le foto perché era il mio mezzo per esprimermi, perché ero con i miei amici alle feste e io ero quella che faceva le foto. Non c’era progettualità: forse è anche il suo bello, è un lavoro del tutto spontaneo, per nulla costruito.

Sei una delle poche ad aver testimoniato la scena rave in chiave fotografica…
Io sono abbastanza strippata per questa cosa del mondo dei rave raccontato in fotografia, mi sento di segnalare un paio di lavori bellissimi sul tema di due autrici inglesi, Vinka Petersen e Molly Macindoe. In Italia invece era uscito soltanto Kaos nel 2005, un’autoproduzione realizzata da Paola Verde, dove c’erano anche delle mie foto. Per il resto, non ricordo altri lavori strutturati degni di nota…
In WHATEVER c’è lo spunto per una riflessione politica? Con quei ritratti intendi forse difendere il diritto politico di ciascuno di essere soggetto?
Non c’è una denuncia espressa da parte mia, ripeto che ho scattato le foto senza troppa sovrastruttura, ma il messaggio politico forse è intrinseco nel movimento rave, e nel libro sicuramente traspare un messaggio perché io racconto esattamente quel momento, racconto di quei giovani che da tutta Europa si spostavano come una grande famiglia, che non si ritrovavano nella società del tempo e che riuscivano a esprimersi solo andando controcorrente…
Quanta nostalgia…?
Ovviamente a rivedersi adolescenti un po’ di nostalgia c’è, perché l’adolescenza è una di quelle cose che non si possono avere indietro. Se la penso dal punto di vista fotografico, invece, mi viene da fare una riflessione: non capisco perché i ragazzi di oggi che vanno alle feste usino così tanto i social, forse lo fanno perché sono nati nel momento in cui il telefono è diventata un’estensione del braccio, ma è un peccato… Ho nostalgia di un mondo in cui la tecnologia non era così presente nelle nostre vite e non dovevamo occuparci tanto dell’apparenza, del risultare…
Fotografia scattata con smartphone e concorsi fotografici dedicati: cosa ne pensi?
Io faccio solo fotografia analogica, e mi sento parte di quella scuola per cui la macchina fotografica è solo un mezzo. Se uno è bravo, le cose le può fare anche col telefono, e questo non vuol dire assolutamente che tutti possono essere fotografi. Faccio un esempio: Piero Percoco che su Instagram è therainbow_is_underestimated, è un bravissimo fotografo, passato anche lui da Cesura, che ha iniziato a fare le foto con l’iPhone semplicemente perché non aveva i soldi per comprare la macchina fotografica. Piero ha creato uno stile, ha pubblicato quattro libri, è stato chiamato per seguire campagne di moda senza mai svendersi ed è riuscito a fare quello che voleva.
Mi infastidisce piuttosto l’idea che se hai un iPhone con tante telecamere sopra, allora sei automaticamente un fotografo, questa è una roba che svaluta l’idea di fotografia.

Qual è, per te, il destino della fotografia?
Non credo di saper rispondere…. ma so dirti cosa mi fa paura: la censura. Oggi il politically correct rischia di diventare censura. Nel nostro lavoro e nella società in generale, questa cosa è molto problematica e preoccupante, per quanto mi riguarda.
Firenze per te…
Firenze la trovo un posto curiosissimo, vivendoci mi sono accorta del fatto che per tante cose è un piccolo paese, ma di una bellezza travolgente, e questa cosa non basta mai. Crescere con quella bellezza e cultura intorno è qualcosa di non scontato e che credo lasci un segno involontariamente. Ed è a Firenze che sono nata come fotografa, quindi è una città che porto nel cuore.
Progetti futuri? A cosa stai lavorando?
Vorrei continuare a fare quello che sto facendo. Al momento sto cercando di chiudere il lavoro che ho fatto sul Villaggio dei fiori – che è il quartiere dove abito a Milano, di case popolari, costruito come fosse Brixton: casette monofamiliari a mattoncini, con un senso di comunità fortissimo, con questo lavoro ho vinto anche il Premio Pesaresi – e portare avanti altre idee, legate anche al diventare adulti… Ho in mente anche un lavoro legato alla provincia che cerco di raccontare perché è da dove sono partita e sono convinta che mi ha dato un’attitudine diversa, una molla per andarmi a prendere quello che volevo. Ora poi sono a Marsiglia, dove sto cercando da anni di raccontare la realtà dei giovani ragazzi che abitano nelle banlieue e spacciano, ma è difficilissimo perché qui la maggioranza è araba, quindi da donna devo combattere lo stereotipo di donna sola, bianca, tatuata… per la prima volta mi sento in difficoltà, non tanto perché fotografa ma perché donna, è terribile.
Comunque intendo continuare a raccontare persone e realtà che sono sotto gli occhi di tutti, ma a cui nessuno presta attenzione. Quando ho vinto il Pesaresi mi sono sentita dire: «Grazie a te, adesso qualcuno ci ha visto…», ecco, questo mi ha riempito di orgoglio e soddisfazione. Dovessi fare le foto tanto per farle, probabilmente non le farei. Ma questo poi è il perché di tutto, perché facciamo le cose sennò…? Never, never, never give up.
Instagram: chiara_fossati
Foto: Chiara Fossati